
Sul primo, ha scritto che Handel è in sostanza scappato da una sfida all'organo e si aggiunga che si permette pure a pagina 194 / 195 del libro "Beethoven" di dare giudizi sul perchè Beethoven abbia preferito Handel: si afferma in sostanza che Beethoven non poteva conoscere le opere tutte le opere di Bach.... perchè non le aveva pubblicate.
Se si analizza la storia delle pubblicazioni, si deve dire effettivamente che molta musica handeliana fu pubblicata durante la vita del compositore, testimonianza questa del successo in vita del compositore e dell’esistenza di una domanda delle sue opere, ma i soli suoi lavori interamente stampati (ad eccezione della musica strumentale) furono Alexander's Feast (1738), Acis and Galatea (1743) e certi Anthems. Dopo la morte di Handel, John Walsh e i suoi successori curarono l’uscita in stampa di gran parte degli oratorii inglesi, ad iniziare da Samson (1763) e il Messiah (1767). Nel 1786 Samuel Arnold propose la sottoscrizione per stampare la mole globale delle opere complete, pubblicazione mai tentata prima per qualsiasi compositore: è evidente che al tempo esisteva ancora un forte interesse ed apprezzamento per la musica Handeliana, tanto da indurre a investire in questo progetto. La stessa cosa non si può dire per Bach dove sia in vita che dopo la morte non c’è stata nessuna ugual iniziativa di stampa per le sue opere, a testimoniare lo scarso interesse per la sua musica, ritenuta eccessivamente rigorosa e schiacciata dal giogo contrappuntistico, come aveva già osservato Johann Adolf Scheibe nel suo Der critische Musicus; siamo infatti ancora molto lontani dalle enfatizzazioni romantiche sul compositore e uomo Bach.
Fra il 1787 e il 1797 quindi uscirono 180 numeri di musica Handeliana, ma non si trattò di per nulla un'edizione completa, se si pensa tra l’altro che solo 4 sono le opere italiane incluse in questa edizione Arnold: vi furono sì molte inesattezze, ma in compenso anche nelle appendici ai volumi oratoriali, molti brani che successivamente non furono più ridati alle stampe. Ecco quindi che si potrebbe osservare in aperta contraddizione con quanto scritto da Piero Buscaroli nel suo libro Beethoven che quest'ultimo poteva avere solo una visione parziale di quanto Handel aveva composto, eppure nel 1823 era giunto alla conclusione che in occasione della visita di Edward Schultz a Beethoven, quest’ultimo affermò con molta decisione in tedesco "Handel è il più grande compositore che sia mai vissuto", in piena armonia con quanto già Haydn nel 1791 affermò nel 1791: « il maestro di tutti noi ».
Buscaroli
sembra dimenticarsi inoltre di riportare - dopo aver
osservato in sostanza che Haydn non avrebbe dovuto lodare una composizione come
il MESSIAH che era di per sé modesta - che Beethoven stesso – grave
dimenticanza visto che avrebbe dovuto essere una biografia imparziale –
nell’occasione della visita di Edward Schultz si mise a parlare del MESSIAH
con una tal passione e nobiltà di linguaggio come la produzione di un genio
immortale, arrivando a pronunciare le parole "Vorrei
scoprirmi il capo ed inginocchiarmi davanti alla sua tomba".
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3870/is_200310/ai_n9327894#continue
Quindi non solo Haydn, ma pure Beethoven si erano resi conto della superlatività del MESSIAH di Handel, eppure lo scrittore Buscaroli sembra essersi dimenticato di questi fatti o ritiene di doverli minimizzare, e francamente sembra sia un suo modus operandi visto che sia in Bach che in Beethoven c’è questa palese faziosità, cosa non accettabile da chi si presenta come biografo/storico. Ma le dimenticanze sull’argomento Handel non finiscono certo qui; infatti ci si dimentica che nel 1824, Johann Stumpff ebbe con Beethoven la seguente conversazione per iscritto (dal momento che ormai Beethoven era del tutto sordo)
- "Chi voi credete sia il più grande compositore mai vissuto?"
- "Handel - fu la sua immediata risposta - a Lui piego il ginocchio", e piegò un ginocchio sul pavimento.
- "Dato che proprio voi in persona, artista incomparabile nell'arte musicale, esaltate così tanto i meriti di Handel più di ogni altra cosa, dovete sicuramente avere le partiture delle sue composizioni"
- "Io? E come io, povero diavolo, avrei potuto procurarmele?"
In quell'istante feci un voto segreto: Beethoven voi avrete le composizioni di Handel cui brama il vostro cuore, ammesso che da qualche parte si trovino.
Nel 1826 Stumpff adempì il voto donando l'edizione di Samuel Arnold delle opere di Handel.
Quanto riportato fa comprendere come Beethoven avesse espresso il giudizio su Handel, solo conoscendo, si ribadisce – una parte della produzione Handeliana, e non conoscendo ogni cosa; anzi proprio questi due riporti storici attesterebbero che già prima di avere una visione più ampia di Handel con gli apporti delle partiture del 1824, già considerava il più alto compositore mai esistito.
L'intento di Buscaroli nel suo libro su Beethoven è un vero tentativo, di persuadere che se Beethoven avesse conosciuto le composizioni di Bach avrebbe espresso un altro nome come “compositore più grande mai vissuto”.
Da sottolineare inoltre che dalla esposizione nel libro di Beethoven, sembra che Ludwig non conoscesse neppure Johann Sebastian Bach: invece non era così in quanto egli studiò il compositore luterano: ecco qui due Links per farsi una idea:
http://www.raptusassociation.org/bachpagesrighte.html
e
http://www.schillerinstitute.org/fid_97-01/002-3bach_beethoven.html.
Nel libro Le Età di Bach e Haendel di Alberto Basso (l'autore che Buscaroli rimprovera perchè non lo ha citato con la giusta importanza, e oggetto del richiamo onirico di Bach apparso in sogno al Buscaroli) si legge a pagina 196 e 197:
"Beethoven guardava con interesse Handel - e il suo era già un ritorno all'antico - ne cantava le lodi in termini di apprezzamento assoluto, ne faceva il capostipite d'una concezione musicale immortale e immacolata. Aveva detto un giorno al musicista inglese Edward Schulz: "Haendel è il più grande compositore che sia mai vissuto" e, scrivendo all'arciduca Rodolfo, il destinatario della Missa Solemnis, a proposito dei suoi studi intorno alla musica antica: "Soltanto Haendel e Bach, hanno avuto del vero genio".
Questo commento è una ulteriore testimonianza del fatto che Beethoven avesse studiato e avesse tra le mani composizioni di Beethoven, altrimenti un simile giudizio se lo si suppone espresso con pochi spartiti di Bach implicherebbe dire che Beethoven era un vero superficiale nell'esprimere un tal parere. Si sa invece non è così (si vedano i due links sopra riportati).
Inoltre in "Beethoven", Buscaroli sembra essersi dimenticato anche che a pagina 93 del suo "Bach" lui stesso riporta:
"
"Non Bach, ma oceano, dovrebbe chiamarsi!"
proruppe una volta Beethoven, in una delle stupende frasi che gli dettava la
nostalgia dell'infinito."
Intanto subito è da sottolineare la parola "stupenda": stupenda per chi? per Buscaroli naturalmente.
Il Termine "Bach" per chi non lo sapesse in tedesco significa "ruscello", ecco quindi il gioco di parole di Beethoven. Ebbene come avrebbe potute pronunciarle se non avesse avuto in mano partiture di Johann Sebastian?
Si ricorda inoltre per completare considerazione che ebbe Beethoven su materiale parziale ricevuto la testimonianza di Gerhard von Breuning, che in tali accenti ne ricordò l'effetto:
"Quando a mezzogiorno come di consueto entrai nella sua stanza, mi fece subito notare quelle composizioni ammucchiate sul pianoforte, mentre i suoi occhi brillavano di gioia.
"Guardate,
questi me li hanno dati oggi. Queste opere mi hanno procurato gran diletto. Per
tanto tempo ho desiderato di averle, perché Handel è il più grande, il più
geniale dei compositori; c'è molto da imparare da lui. Per l'appunto datemi
ancora quei libri!"
E come la storia dimostra quei libri di cui si parla nell’aneddoto storico non erano sicuramente completi; bisogna attendere il 1843, quando la English Handel Society, allo scopo di emettere un'edizione accurata e definitiva delle opere di Handel, riuscì, pubblicandoli sino al 1858, a stendere almeno 16 volumi di oratori, anthems e duetti. Lo sforzo poco si discostò tuttavia ancora poco dalla edizione Arnold, ad eccezione dell'edizione del Belshazzar curata da G.A. Macfarren.
L'edizione della Händel-Gesellschaft tedesca, creata quasi per intero ad opera dell'alacrità del solo Friedrich Chrysander, rimane sinora uno dei capisaldi di una esposizione abbastanza esaustiva. Si pubblicarono 93 volumi nell’arco di tempo fra il 1858 e il 1902, assieme a riedizioni rivedute di singoli volumi (in particolare i volumi XXXII, LVIII e parte di XLVIII), a 2 facsimili d'autografi (Jephtha nel 1885 e il Messiah nel 1892) e a 6 volumi di supplemento con opere di altri autori da cui Handel attinse. Relativamente al volume XLIX (musica vocale miscellanea) Moeck fece fatto una tiratura nel 1960 non essendo mai uscito prima. Sebbene Chrysander attinse i suoi dati dagli autografi, la fonte essenziale della sua edizione rimasero le partiture direttoriali (ossia le copie manoscritte utilizzate da Handel stesso per l'esecuzione delle proprie opere) raccolte nella Staats- und Universitätsbibliothek di Amburgo.
Sebbene lodevolissima ed ingente impresa del tempo, l'edizione Chrysander è inficiata da una selezione piuttosto soggettiva del materiale e delle fonti per le opere dalla tradizione più complicata, nonché dalla mancanza d'informazioni relativamente al metodo editoriale adottato, di volta in volta seguito dal curatore. Per esempio la rinumerazione delle sonate dell'opera I e II da parte di Chrysander, effettuata per includere brani che non ne facevano parte in origine, hanno provocato confusioni ancora non totalmente eliminate. Opere minori, come i brani Aylesford per cembalo e le nove arie tedesche, si accorparono alla spicciolata al corpus dell'opera handeliana.
Nel 1955 la città natale di Handel, Halle an der Saale, ha varato un nuovo progetto editoriale, la Hallische Händel-Ausgabe. Inizialmente quest'edizione fu concepita come mero supplemento e revisione dell'edizione Chrysander, ma nel 1958 fu trasformata in una edizione critica in senso stretto. Questa svolta di politica editoriale, si manifesta nel livello assai diseguale di attendibilità e affidabilità dei volumi pubblicati recentemente.
Halle diede un nuovo impulso nella ricerca handeliana ottenendo un risultato ottimale: il catalogo tematico delle composizioni (Thematisch-systematisches Verzeichnis) di Bernd Baselt e pubblicato in 3 volumi sotto la denominazione di Handel-Handbuch (1978-1986). La numerazione delle opere secondo il catalogo Baselt (lo Handel-Werke-Verzeichnis, abbreviato correntemente in HWV) è ormai entrata nell'uso universale.
Tornando ancora sul concetto dell'assenza pressocchè totale di pubblicazioni bachiane, è da osservare che se non c'è stata pubblicazione e stampa è perchè i coevi si erano resi conto che intraprendere la stampa era molto rischioso perchè esisteva il reale rischio che non si sarebbe riusciti a vendere niente o molto poco, tanto da non poter coprire i costi, e quindi l'impresa sarebbe inevitabilmente fallita: qui si dimostra la saggezza di Bach nel non intraprendere una pubblicazioni fallimentose, e non per ipotetiche decisioni legate ad un sentire superiore, staccate dalla materialità degli incassi.
A pagina 808
di Bach troviamo un
altro colpo basso contro Handel e un silenzio squarciante sulla nota succitata
circostanza dell'espressione del pensiero di Beethoven su Handel:
"Una predilezione di Bach per l'opera giovanile di Handel è, in ogni caso, fuori discussione, mentre nessuna corrispondente premura, o apprezzabile conoscenza, si riscontrano nel lavoro del coetaneo, nonostante gli sforzi dei suoi più recenti studiosi, preoccupati di dissolvere un sospetto di scortesia o di superbia".
Ci si dovrebbe chiedere dove sta scritto che Handel doveva avere delle opere di Bach, come segno della stima verso il luterano di Eisenach: ciò che scriveva Bach evidentemente non interessava molto ad Handel, per quale motivo avrebbe dovuto procurarsi delle partiture bachiane che per loro natura esulavano dal modo espressivo Handeliano? Handel non parve interessato neppure molto allo stile Vivaldiano: eppure non sembra che ci siano stati grossi problemi. Questo è dovuto ad un modo di sentire, e francamente il fatto giova ad Handel in quanto ciò ha permesso la mancanza di un tipo di scrittura spesso matematico e poco melodica: in questo senso sì che si potrebbe condividere la titolazione di pagina 945 "Un solo Bach". Comunque sia ripresentare una frase come quella su riportata fa leggere fra le righe un Handel superbo e scortese - altro colpo a segno contro Handel; anche Gabriella Mazzola Nangeroni, nel suo libro Haendel riporta l'idea che « nei secoli successivi, soprattutto nel periodo romantico, molti hanno rimproverato a Handel il suo totale disinteresse per le magistrali pagine musicali del suo contemporaneo: Questo non è completamente vero, tanto che nella sua biblioteca sono state trovate anche composizioni a stampa del grande Johann Sebastian e il suo atteggiamento, forse non particolarmente disponibile, può essere attribuito tanto a indifferenza, quanto al fatto che non sa chi fosse veramente quel grande kapellmeister, nato non lontano da dove era nato lui e nello stesso anno; egli lo credeva uno dei tanti maestri di cappella che davano lustro alla Germania, la cui abilità però si esauriva nell'essere un improvvisatore di fughe e un imbattibile contrappuntista. »
Ma la pagina 808 nasconde altri silenzi impertinenti:
"Interesse, curiosità, entusiasmo per il lavoro altrui non soltanto non sono segni di modestia, o di sottomissione, o riconoscimenti di inferiorità come nelle opinioni ingenue e volgari. L'entusiasmo, il tributo di elogi, le premure testimoniate da Beethoven a Cherubini, o da Bruckner a Wagner, e gli altezzosi silenzi, o la distratta condiscendenza con cui furono (o non furono) ricambiati soltanto, a parte ogni pettegolezzo sulle stature artistiche degli uni o degli altri, da quale parte stiano le doti della grandezza d'animo."
Qui si denota un contrasto: da un lato Beethoven e Bruckner, e quindi Bach sono presentati al lettore come dei virtuosi, o meglio con le parole di Buscaroli hanno le "doti della grandezza d'animo", mentre Handel, Cherubini e Wagner sono dei superbi o ingrati per i tributi mostratigli. Se non è una strumentalizzazione questa dei fatti storici, volta a distruggere umanamente Handel come uomo, per lo meno non sono di certo fatti storici provati.
Manca inoltre la citazione delle fresi ed il pensiero di Beethoven relativamente ad Handel: più azzeccato di questo come momento per inserirlo nella pagina 808 di Bach non ce ne sarebbe stato, per lo meno in nota: invece niente: silenzio! Ma si può comprendere, le parole di Beethoven verso Handel non potevano sottendere solo entusiasmo o tributo elogiativo, ma invece dar credito ad un vero e proprio segno di sottomissione....e questo è davvero inconcepibile per l'autore questo, perchè con solo quelle frasi storiche si intacca in un colpo solo Beethoven e Bach (i pupilli di Buscaroli) a vantaggio della statura artistica di Handel: in sostanza Beethoven elogia Handel con toni molto forti, quindi con un senso di modestia e sottomissione, e d'altro canto il gesto colpisce Bach perchè non viene neppure considerato da Beethoven.
Anche pagina 807 da Bach, il Buscaroli riporta, e quindi chiamiamo in causa anche il suo libo "La Nuova immagine", pagina 77, viene riportato:
"Come molti autori, anche noi scorgeremmo nel rifiuto di Handel (alla conoscenza di Bach, non alla sfida) il " senso di superiorità sociale che un musicista libero di carriera internazionale, orgogliosamente pieno di sè quale il Sassone era, doveva provare nei confronti di un funzionario mai uscito dalla regione d'origine"
A rincarare la dose contro Handel - sebbene sia solo un riporto nelle note in Bach di Buscaroli a pagina 255 commenti su Bach di Wilibald Gurlitt, il quale nel suo "Das historische Klangbild im Werke J.S.Bach" pagina 40 - 44 e in pag. 68 - 73 di "Musikgeschichte und Gegenwart", II, Wiesbaden 1966, riferisce che per seguire i suoi lavori di restauro dell'organo Bach dovette tornare apposta da Weimar, dove ormai si trovava perché il giovane Bach dedicava tutte le sue forze "ad majorem dei Gloriam" in un'età in cui il coetaneo Handel, volte le spalle alla chiesa, si era dato al secolo e al mondo. (Come se Handel non avesse MAI composto musica sacra o musica di soggetto sacro!!!!!!!!) Si evince chiaramente anche da questa biografia un continuo discredito contro Handel, instillando nei lettori una ammirazione per l' uomo Bach che ha dedicato tutta la vita per uno scopo superiore (e quindi anche la sua musica quale manifestazione del suo essere) e dipingono Handel come un perditempo, un non credente, uno che si dava alla moda e in sostanza alla vanità e futilità del mondo, e quindi la sua musica risulta futile, di circostanza, figlia dell'Ancien Régime, con tutta la visione negativa che ebbe questo mondo ante rivoluzionario.....
Neppure sulla disgrazia della cecità il Buscaroli si risparmia per colpire Handel e dipingere la grandezza di Bach: a pagina 1113 scrive riferendosi al chirurgo Taylor, che poi era il millantatore che operò anche Handel:
"ERA ARRIVATO IL BUIO. Partito l'inglese con le sue ciarle, i suoi manifesti e la collezione di ferri chirurgici di cui usava allestire mostre «collaterali» per invogliare la clientela, restava al Thomas-Kirchhof un cieco in progressivo declino. «Non solo aveva perduto completamente la vista, ma anche la sua salute era rovinata. » Che cosa disse? Possibile che la leggenda familiare non registrasse un'invettiva, un lamento, una preghiera? Quando capì d'essere cieco, Handel cominciò a dettare il suo proprio inno funebre:
"Total eclipse! No sun, no moon!
All dark amid the blaze of noon"
che John Beard cantò nella commozione generale. Bach non ha mai aperto uno di questi squarci patetici su se stesso. Era ancora l'ascoltatore segreto, capace di sedere quattro mesi di fila nella Marienkirche di Lubecca a sentire Buxtehude senza rivelarsi, né confidarsi. Trascorse anche gli ultimi quattro mesi senza rivelarsi, né confidarsi. Quel che aveva da dire continuò a dirlo attraverso la musica, ma senza accenni personali. Al buio...."
Che vuol dire non ha mai aperto squarci patetici su se stesso?
Si insinua quindi che Bach è stato più bravo perchè ha vissuto il suo dramma dentro se stesso? Inoltre chi ha detto che la frase di Samson fosse stata scritta per comunicare al pubblico la situazione di Handel personale? è stato il pubblico inglese a sentirsi colpito dalla frase, perchè fecero *loro* un paragone con la situazione di Handel, e si commossero all'ascolto di quella frase forse in esecuzioni successive al 1750....non è provato che Handel volesse parlare di sè nell'oratorio; si aggiunga inoltre che le prime vere crisi visive le ebbe nel 1750/1751 in relazione alla stesura del suo coro "How dark, O Lord, are thy decrees" ossia "Come sono oscuri, o Signore, i tuoi decreti" nell'ultimo suo oratorio JEPHTA (come si afferma anche a pagina 278 di Georg Friedrich Handel di Christopher Hogwood): si sottolinea che il Samson risale al 1743, quando la vista di Handel era sana come quella di un falco!
E comunque, Bach rimase completamente cieco solo per pochi mesi, dai 4 ai 6 al massimo, prima di andarsene. Handel invece dovette conviverci per almeno 6 anni (dal 1752-3 alla fine). Buscaroli sembra dimenticarsi che Handel, sebbene cieco, continuò a cimentarsi nella musica: per esempio i concerti per organo, che erano divenuti una caratteristica fissa delle sue esibizioni pubbliche, rimasero una attrazione sino alla fine della sua vita: per Handel nè paralisi, nè cecità incipiente riuscirono ad intaccare la sua fama incontestabile di virtuoso alla tastiera (pagina 195 Handel di Christopher Hogwood).
E proprio per esser polemici, supponendo che le affermazioni storiche di Buscaroli fossero vere, che senso ha sottolineare che Bach continuò a comunicare ciò che aveva da dire attraverso la sua musica? E l'oratorio SAMSON cosa sarebbe per il Buscaroli? Non musica!!!!!
A pagina 475, sempre del libro Bach, in occasione del racconto del mancato scontro organistico fra Bach e Marchand, il Buscaroli scrive, dopo alcuni paralleli militari di Pompeo dopo Farsalo (ecco si vede sempre questo concetto di vita di Bach = vita di uno degli eroi della antichità):
"Il racconto di Marpurg è prezioso, non solo per la serietà della fonte, ma perchè mette a dimora nella nostra mente un'altra fuga, ancor più svalutata, che tuttavia vedremo non meno autentica, di fronte alle prospettiva di misurarsi con Sebastian Bach: quella di Handel".
Il mancato incontro innanzitutto avvenne per due volte.
Nel 1719 Handel partì da Londra per cercare nel continente grandi cantanti da scritture per la Royal Academy; fu un lungo viaggio che toccò Dusseldorf e sopratutto Dresda, dove soggiornò per diversi mesi. Johann Sebastian Bach manifestò il proposito di conoscere il maestro del quale ormai tutta la Germania parlava, e pare che partendo da Cöthen, abbia affrontato un viaggio di circa 20 miglia per incontrarlo, ma lo mancò di pochi giorni: quindi un mancato incontro da ascriversi alla tempistica dei movimenti dei due compositori. Secondo le ricerche di Christhopher Hogwood, si tratta di una leggenda si veda all'uopo pagina 88 del suo libro Georg Friderich Handel.
Esattamente dieci anni dopo in un altro viaggio di Handel in Europa alla ricerca di cantanti, il primogenito di Bach, Wilhelm Friedemann, lo l'invitò ad incontrare suo padre a Lipsia, ma pare che Handel declinò l'invito. Secondo Hogwood non esistono sufficienti indizi che testimonino l'effettivo invito del figlio di Bach e il conseguente rifiuto di Handel, ma se consideriamo attendibile l'aneddoto, possiamo azzardare una spiegazione, desunta da una serie di fatti e circostanze riferiti da Burney, Mainwaring e Mattheson (e sono tre contro Marpurg):
Handel era, oltre che un eccellente compositore di opere, anche un uomo d'affari che aveva investito parecchio denaro per il successo della sua attività teatrale. Nel giugno del 1728 era accaduto che tutti i cantanti avevano lasciato l'Inghilterra dopo la chiusura dell'Accademia e per lui diventava fondamentale trovare grandi cantanti che richiamassero parecchio pubblico nel suo teatro, a discapito di quello dei rivali.
Il Daily Post del 27 Gennaio 1729 annunciava che "Mr. Handel, famoso compositore di musica italiana" era partito per l'Italia su incarico della nuova Accademia Reale di Musica: probabilmente doveva affiancarsi al "socio" Heidegger che stava già esplorando i palcoscenici italiani. C'erano problemi, perché le loro scelte non trovavano "giusta mercede": Farinelli aveva rifiutato l'ingaggio, la Cuzzoni non voleva tornare per un'altra stagione e la Bordoni si era sistemata a Venezia col marito Hasse; sicché c'era un'assoluta necessità di trovare nuovi cantanti, e al più presto. Fatto sta che Michaelsen gli fece sapere che sua madre Dorothea era molto malata; così Handel affrettò la partenza dall'Italia: passò velocemente per Hannover ed arrivò ad Halle all'inizio di giugno. La madre, vecchia e cieca, era in punto di morte, per cui Handel passò con lei il poco tempo che aveva, *rifiutando tutti gli altri inviti* e uno di questi proveniva da J.S.Bach, che era malato ed aveva mandato come ambasciatore il figlio maggiore Wilhelm Friedemann, affinché *pregasse* il famoso collega di andare a trovarlo a Lipsia. Ma il primo Luglio Handel era già tornato a Londra, per tentare di dare inizio all'avventura operistica... (questa posizione è espressa da Paul Henry Lang sul suo libro biografia Handel a pagina 261 / 262)
La posizione invece di Gabriella Nangeroni è che (Nangeroni, Haendel pagina 87):
"Per restare accanto alla madre, l'unica donna che egli abbia sinceramente amato, rinviò ogni visita ufficiale e, sia pure con una certa amarezza, rinunciò anche all'incontro con il collega Johanna Sebastian Bach che tramite il figlio Wilhaelm Friedemann lo aveva invitato a Lipsia. Dopo la scomparsa della madre, con profondo dolore ma anche con grande dignità, lasciò la Germania e rientrò a Londra..."
Invece a pagina 112 dal libro Georg Friderich Handel di Christopher Hogwood, si legge:
"Si suppone - a dire il vero lo si spera - che abbia fatto visita alla madre ad Halle (se sì, ciò accade un mese prima di quello che aveva previsto), ma di sicuro non ha alcun fondamento la storia del presunto rifiuto dell'invito che Johann Sebastian Bach gli avrebbe rivolto attraverso il figlio Friedemann (che allora viveva ad Halle) affinchè lo andasse a trovare a Lipsia."
Si aggiunga una considerazione: supponendo veri i due presunti tentativi di incontro su menzionati, solo Bach avrebbe tratto giovamento da un possibile sfida, dal momento che, vincesse o perdesse, i riflettori d’Europa si sarebbero spostati momentaneamente sul duello musicale, e quindi Bach in sostanza avrebbe brillato della luce riflessa di Handel, acquistando un notorietà europea; ma il lato più triste che si possa desumere dei due presunti tentativi di Bach di entrare in un confronto con Handel è che sia nel 1719, che nel 1729 Bach ricercava disperatamente una notorietà vera e non locale che continuava, forse anche ingiustamente per certe composizioni, ad avere.
Adesso trattiamo l'argomento Organo, inteso sia come invece sulla abilità tastieristica sia su quella compositiva, in un diretto confronto fra Bach ed Handel.
E' possibile credere che tutto sia iniziato dal mancato certamen fra Bach ed Handel nel 1729, quando Bach attraverso il figlio maggiore Freidemann aveva portato l'invito di suo padre per attrarre a Lipsia Handel. Buscaroli, come si è evidenziato sopra, sembra conoscere il carattere di Bach, e fa intendere che Bach si fosse vantato del non scontro con Handel, a pagina 808, dove scrive
"Modesto come era, non avrà certo mancato di trarre dall'episodio la giusta dose di vanto, facendo girare l'episodio più che poteva".
Come detto nella sezione intitolata "Sul Mancato Incontro" Hogwood nega che ci siano prove certe di questo invito, ma per Buscaroli:
"Quali che fossero le cause, il rifiuto di Handel è innegabile: nel 1729, davanti alla Lipsia che s'interessava di queste cose, Bach fece la figura di un musicista, la cui fama di improvvisatore e di virtuoso aveva scoraggiato un Handel dalla tentazione di saggiare un confronto".
E' probabile allora che, anche per contrastare le borie tedesche, nel 1785 Charles Burney pubblica: "An Account of the Musical Performances in Westminster-Abbey", che in tali accenti così intona:
"Che Handel fosse superiore, nell'energia e nell'audacia dello stile,
nella ricchezza dell'armonia, nella complessità del trattamento delle voci, a
qualsiasi compositore che sia mai stato ammirato per queste particolari capacità,
è una verità indiscutibile. E per tutto il tempo in cui la fuga, l'invenzione
e il contrappunto vennero considerati più di quanto non accada oggi, egli
rimase del tutto insuperato.
So che si è detto che Handel non fu l'originale e primo inventore di diversi
generi musicali per cui il suo nome e stato celebrato; ma, per quanto concerne
l'originalità, si tratta di un termine cui bisogna porre limiti convenienti,
prima di applicarlo alla produzione di un qualsiasi artista.
Ogni invenzione è incerta e appena sbozzata all'inizio, e Shakespeare non fu il
primo scrittore di commedie, né Corelli fu il primo compositore di musica per
violino, sonate e concerti, anche se quanto produsse per questi generi fu il
meglio del suo tempo; e nemmeno Milton fu l'inventore del poema epico.
Una volta fissati la tonalità, l'armonia e il ritmo della musica è impossibile
per qualsivoglia musicista inventare un genere di composizione completamente e
rigorosamente nuovo, almeno quanto è impossibile per un poeta crearsi un
linguaggio, un idioma e una fraseologia. L'inventore musicale più grande e
audace può invece servirsi dei migliori mezzi espressivi, combinazioni, effetti
utilizzati dai suoi predecessori per rielaborarli, applicarli in modo nuovo e
aggiungere, attingendo al proprio genio, tutto ciò che è grande, grazioso,
lieto, patetico, o, comunque, piacevole. Handel fece questo in modo grandioso e
superiore, poiché era padrone, negli anni della maturità e del pieno vigore,
di ogni raffinatezza e perfezione proprie del suo tempo. Egli univa l'arte
profonda ed elaborata del suo paese natale con l'eleganza e la fluidità
italiane: sembra infatti che, durante il suo soggiorno a sud delle Alpi, egli
abbia ascoltato attentamente, nelle chiese, nei teatri, nelle sale da concerto,
le migliori composizioni e i più grandi esecutori del tempo, di ogni genere e
campo. Esistevano già cantate di Carissimi, Alessandro Scarlatti, Gasparini e
Marcello; duetti di Steffani e Clari; composizioni corali senza accompagnamento
strumentale di Palestrina e dei nostri Tallis, Bird e Purcell e con
accompagnamento strumentale di Carissimi e Paolo Colonna; sonate e concerti per
violino di Corelli e Geminiani; ma si può affermare in tutta verità che Handel
aggiunse, a qualsiasi stile o genere musicale adottasse, molto di rilevante e di
bello, come sarebbe facile dimostrare, in una trattazione più ampia, attraverso
qualche esempio. Qui vorrei solo affermare, come articolo della mia profession
de foi musicale, che le sue arie o melodie sono assai superiori a quelle che si
possono trovare nelle cantate, peraltro affascinanti, che vengono attribuite a
Carissimi; che egli è più naturale nel trattamento delle voci, e il movimento
del basso è, nelle sue composizioni, più vario che in quelle di Alessandro
Scarlatti; che è più vigoroso e originale di Gasparini e Marcello; che i suoi
detti da camera sono almeno al livello dì quelli di Steffani e Clari, che però
non crearono nulla di notevole negli altri generi; e, sebbene il defunto Dottor
Boyce fosse solito dire che Handel doveva molto a Colonna per quanto riguarda le
sue composizioni corali con accompagnamento strumentale, sembra inconfutabile
che questo genere debba molto di più a Handel di quanto quest'ultimo sia
debitore a Colonna o di quanto le composizioni corali con accompagnamento siano
debitrici a qualsiasi altro compositore. Credo inoltre che le sue migliori arie
d'opera italiana superino, per la varietà dello stile e la semplicità degli
accompagnamenti, quelle dì tutti i compositori europei del passato e del
presente, che nelle sue composizioni per violino ci sia più fuoco che in quelle
di Corelli e più ritmo che in quelle di Geminiani; che nelle fughe per organo
più mature, magistrali ed eccellenti, composte su temi estremamente ingenui e
piacevoli, egli superò, oltre a Frescobaldi e persino a Sebastian Bach, altri
fra i suoi compatrioti rimasti celebri per l'abilità in questo difficile ed
elaborato tipo di composizione; e, infine, che tutti i musicisti intelligenti e
senza pregiudizi di ogni paese, dopo avere ascoltato o letto i nobili,
magistrali e spesso sublimi anthems corali o i cori degli oratori,
ammetterebbero spontaneamente, con rapimento, dì non aver mai conosciuto nulla
di simile tra le opere dei grandi maestri che sono stati attivi da quando fu
inventato il contrappunto."
Tali considerazioni, furono subito tradotti in tedesco e scatenarono le reazioni di uomini offesi; a pagina 806 del libro Bach di Buscaroli si legge: " ....era sbollita l'ira del *superficiale* paragone del Burney tra Handel e Bach apparso a Londra nel 1785 e subito tradotto in tedesco, che aveva suscitato in uomini come Emanuel e Forkel, inducendoli a mettere le cose a posto".
Il fatto di considerare Charles Burney superficiale può derivare dal fatto che era soltanto in fondo un musicologo, uno scrittore: pochi sanno invece che aveva competenze musicali, e che per di più era anche organista, ma Buscaroli colpisce anche il lavoro descrittivo della realtà musicale europea di Burney, infatti a pagina 271 si legge:
"L'esplorazione del vero stato della musica del suo tempo, che costituirà il tema della sterminata e confusionaria dissertazione del dottor Burney, Sebastian Bach la compie criticamente, da compositore"
col rincaro della dose a pagina 342 in occasione di un implicito confronto fra Forkel e Charles Burney: "...(e Forkel è il fondatore della storiografia musicale, per cui Charles Burney aveva soltanto affastellato cumuli eterogenei di materiali)"
Non si può quindi iniziare coll'osservare innanzitutto che il Forkel nel raccontare Bach, con una faziosità impressionante che farebbe perdere la calma anche ad un santo, attinge le informazioni e riporta considerazioni dei figli di Johann Sebastian: questo dovrebbe già far riflettere sulla mancanza di una oggettività intrinseca, perchè i figli mai avrebbero parlato male del loro padre: è come entrare in una osteria e chiedere all'oste se ha vino buono..... Infatti a pagina 79 si legge sempre in Bach:
"La vigorosa affermazione della superiorità di suo padre,
(è Carl Philipp Emanuel, il secondo dei maschi, figlio di Bach che dovrebbe esser più obiettivo di Charles Burney, perchè Buscaroli dice che "mostrava di saper misurare e compendiare i meriti di suo padre al di fuori dell'encomiastica famigliare e dei suoi luoghi comuni correnti")
come compositore di fughe, su Handel, un passo della cui biografia, contenuta nella Storia del Burney, gli aveva dettato l'appassionata precisazione, contiene già i fondamenti tecnici e poetici dell'odierno giudizio".
Ode al sig. Handel, Sulla sua abilità di
organista
di Daniel Prat, Rettore di Harrietsham, Kent.
In passato Cappellano della Famiglia di Sua Maestà in Kensington.
I.
Come potranno ancora le Muse insegnare,
Artista Divino! nel comporre melodie,
quale voce con egual pensiero musicale potrà raggiungere
la tua, e meritarsi l'eccellenza nell'arte dell'organo?
Oh! possano i versi scorrere con la stessa scioltezza,
con la quale tu comandi ai nostri spiriti,
che si innalzano e ricadono esattamente guidati,
ossequiosi ai movimenti della tua mano.
II.
Ripieni di gioia e di stupore, ci sentiamo
portati e sollevati sulle onde sonore,
come Giacobbe nel suo sogno beato,
che si avvicina ad osservare il Cielo!
Poi con note più lente e prolungate
ascoltiamo, e ci pervade sacro terrore,
l'organo suonare maestoso e profondo,
emblema dei suoni che risvegliano i morti!
III.
Piacere e sgomento riempiono il Tempio!
le statue che si ergono sulle antiche tombe
guardano fisse, mentre noi diventiamo come loro!
ecco! stiamo tutti immobili come statue,
incantati dalla tua magica mano!
Segue una pausa solenne ......
Tutto è azzittito, ogni respiro
sembra gelato nelle braccia della morte!
Le passioni irrequiete dolcemente assopite;
solo la mente non cessa di pensare!
Che luogo tremendo! Che fremito di sacra paura
ci fa tremar le vene! salve coro celeste
che canti attorno all'Eterno! perché qui certamente
c'è il Signore! e voi profani allontanatevi.
Ascoltiamo di nuovo! e il silenzio ora è sommerso
in una rapina di note, in un'estasi di suoni!
I.
Incantato in una solenne meraviglia
il rustico garzone, un bruto umano,
divora i suoni, in profondo stupore
rapito, immobile, muto.
La sua anima comincia a risvegliarsi, e scommette
che dietro quell'apparenza abita un Dio,
convinto che niente di inferiore
potrebbe dare cosi meravigliosi e dolci suoni.
II.
Quale maledetta furia agita i petti
di quelli che, con zelo più che barbaro,
urlano contro il dolce incanto della musica,
capace di addomesticare le fiere?
Cosi le Furie che dilaniarono il greco cantore,
e con la loro assordante gazzarra sommersero
ciò che gli alberi e le rocce ascoltavano incantati,
il suono melodioso della voce e dell'arpa!
III.
Ed io, dalla voce non educata a innalzarsi,
non tacerò per rifugiarmi in un cantuccio silenzioso,
perché le tue note reclamano l'encomio,
e sì! è da esse che ho tratto la forza!
Ma quando i miei poveri versi cominciano a scorrere,
appena essi cercano di narrare la tua bravura,
ecco che - abituata a strisciare -
la mia fantasia s'innalza troppo e cade.
Così l'uccellino, abituato all'ombra e al silenzio,
ascolta le variazioni di un grande musico:
la sua animuccia eccitata mette alla prova le sue note,
l'uccellino si mette a cantare in competizione con l'artista:
cinguettando si sforza e prova tutte le modulazioni,
finché esausto, abbassa le sue deboli ali, e afflitto muore.
Questo, in versi italiani, dolcemente Strada cantò,
e ancor più dolcemente Philips, nella nostra lingua.
[…]
Lo
I suoi

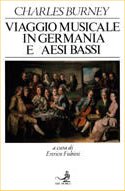
Gli aneddoti di Burney su Handel
In un'epoca in cui i compositori erano anche esecutori e dovevano saper suonare le proprie opere se volevano che fossero conosciute, Handel utilizzò le sue creazioni strumentali, soprattutto quelle per tastiera, come un mezzo per dimostrare la sua straordinaria abilità esecutiva, che si manifestò fin dalla giovinezza.
Dal periodo italiano ci sono rimasti alcuni gustosi aneddoti:
Francesco Valesio, alla data del 14 gennaio 1707 annotò nel suo diario romano: « E' giunto in questa città un Sassone, eccellente suonatore di cembalo e compositore di musica, il quale oggi ha fatto gran pompa della sua virtù in sonare l'organo nella chiesa di San Giovanni con stupore di tutti » (Archivio Storico Capitolino).
Mainwaring,
ci racconta la sfida tra Handel e il coetaneo Domenico Scarlatti, figlio del
grande Alessandro, che gli ammiratori di Handel organizzarono in casa Ottoboni.
Fu una serata straordinaria dove, due dei più virtuosi cembalisti del tempo, si
esibirono in prodezze d'improvvisazione all'organo e al cembalo. Alla fine, i
due si divisero equamente gli allori al clavicembalo, mentre Scarlatti riconobbe
generosamente la superiorità di Handel all'organo.
Ma lasciamo raccontare a Mainwaring:
"Giacché suonava [Domenico Scarlatti] assai bene il clavicembalo, il
cardinale Ruspoli decise di metterlo a confronto con Handel per una gara di
abilità. L'esito della prova al clavicembalo è stato variamente riportato. Si
dice che alcuni diedero la preferenza a Scarlatti. Ma quando si misero
all'organo, non ci fu più alcun dubbio su chi fosse il migliore. Lo stesso
Scarlatti riconobbe la superiorità dell'antagonista, confessando candidamente
che prima di avere sentito Handel all'organo non aveva idea delle enormi
possibilità di questo strumento. Rimase così impressionato dal suo speciale
modo di suonare che lo seguì ovunque in Italia né era mai così felice come
quando stava con lui.
[...] Benché mai due esseri umani abbiano attinto a una tale perfezione nel
proprio rispettivo strumento, va tuttavia notata l'assoluta diversità del
loro modo di suonare. Sembra che il tratto caratteristico di Scarlatti
consistesse in una certa eleganza e delicatezza di espressione. Handel da parte
sua sfoggiava una brillantezza ed un controllo delle dita non comuni, ma ciò
che lo distingueva da tutti gli altri esecutori dotati delle medesime qualità
era quello stupefacente senso pienezza, di forza e di energia col quale egli le
vivificava."
Anche Denis Nolhac, un visitatore francese a Roma, testimonia l'abilità di Handel, quando assistette ad un ricevimento dato dai musicisti del Papa, dove Handel si esibì suonando il clavicembalo. Siccome egli era di fede luterana, si suppose che fosse in combutta col diavolo. Handel suonava col suo cappello sotto il braccio e si pensò che il cappello avesse un'influenza soprannaturale. Nolhac riferì a Handel quello che si stava dicendo e lui stupì tutti lasciando cadere il cappello e suonando in modo anche migliore.
Altro aneddoto sulle capacità "diaboliche" di Handel è quello riferito da Mainwaring: Handel nel dicembre del 1709 fu scoperto a Venezia ad un ricevimento in maschera, mentre suonava il cembalo, anche lui in maschera. Capitò che fosse presente Domenico Scarlatti, il quale affermò che non potesse trattarsi che del famoso Sassone, oppure del diavolo in persona.
Anche l'amico amburghese Mattheson testimonia le capacità di Handel nel suo trattato più importante, "Der Vollkommene Capellmeister" (1739): "In particolare nessuno supera Handel nel suonare l'organo; a meno che quella persona non sia Bach, a Lipsia: perciò questi due devono, indipendentemente dell'ordine alfabetico, raffigurare pari in grandezza. Li ho sentiti in tutta la forza della loro arte e ho suonato anche talvolta col primo, tanto ad Amburgo che a Lubecca."
Michael
Festing e Thomas Augustine Arne ebbero modo di ascoltarlo all'organo ad Oxford
nel 1733 e riferirono a Burney:
"che né loro, né alcun altro di loro conoscenza aveva mai sentito tanta
bravura nel suonare sia all'improvviso sia premeditatamente, su quello
strumento o su qualsiasi altro".
L'improvvisazione di Handel, a detta di Hawkins, si distingueva poiché:
"soggiogava l'orecchio seguendo una progressione lenta e solenne; l'armonia
era intricatissima e piena al massimo, i passaggi concatenati con abilità
stupefacente, e il tutto era nel contempo perfettamente intelligibile eppure
dotato all'apparenza d'una gran semplicità".
Burney ne descrisse il tocco cembalistico come:
"tanto morbido, e il suono dello strumento talmente accarezzato, che
pareva che le sue dita fossero concresciute nei tasti. Quando suonava, esse
erano talmente ricurve e compatte che non s'intravedeva alcun moto, e a malapena
si distinguevano le dita stesse".